Le statistiche ci hanno insegnato a leggere la realtà del lavoro attraverso i numeri, così occupazione, disoccupazione, inattività – se letti al femminile – evidenziano differenze tutte a nostro sfavore.
Per una volta vorrei tralasciare una puntuale analisi quantitativa, e riflettere su alcune storie che ho raccolto negli ultimi sei mesi di attività, in territori e settori diversi, sia in ambito pubblico che privato. Per ovvie ragioni cambierò nomi e circostanze, rimarranno i fatti.
Marina, assistente alla poltrona presso un dentista, lavora dalle 13 alle 20. Dopo aver comunicato la propria gravidanza al datore di lavoro, la norma prevede che qualora non possa essere destinata ad altra mansione (a tutela di madre e bambino) debba usufruire dell’astensione anticipata per maternità. Niente paura, l’azienda provvede a modificare la mansione destinandola a lavoro di segreteria. In teoria, perché in pratica continuerà a fare il solito lavoro di assistente alla poltrona. Accetta questa situazione, pensa che la sua disponibilità sarà premiata, ma dopo la maternità obbligatoria a fronte della richiesta di collocare le ore di allattamento a fine turno, per uscire alle 18 e seguire la fase transitoria prima del definitivo rientro, si sentirà rispondere che l’azienda non può farsi carico delle sue esigenze.
Luca e Giovanna, lavorano nella stessa azienda a turni. Hanno due figli e non hanno rete parentale. Da anni si organizzano lavorando su turni diversi, in questo modo riescono a far fronte alle esigenze di cura familiare. Con il cambio della dirigenza le loro richieste non “possono essere prese in considerazione” viene detto loro di organizzarsi con delle baby sitter.
Lucia, Miriam e Carlotta, il loro capo struttura parla troppo. Continuamente esprime giudizi sulle donne, “complimenti” secondo lui, vere e proprie molestie verbali secondo loro. Per lui è un modo per essere spiritoso, per loro diventa una realtà insopportabile, reiterata ogni giorno alla quale ogni operazione di contrasto messa in atto diventa occasione di ritorsione sul lavoro.
Caterina ha un lavoro che fino a qualche anno fa ero svolto solo da uomini. Opera a contatto con il pubblico, in un regime di regole che occorre far rispettare e lei, come i colleghi maschi, ne esige il rispetto. Ma talvolta capita che l’utente, se di genere maschile, poco accetti che a dettare le regole sia una donna. Caterina ha subito un’aggressione durante l’orario di lavoro e non è l’unica lavoratrice ad esser stata vittima.
Luisa è un tecnico, e svolge la sua attività con molta competenza ed autonomia. Nell’esercizio del suo ruolo rileva e denuncia un comportamento scorretto da parte di alcuni colleghi, comportamento che la porta a non poter svolgere quanto a lei affidato. È precisa e puntigliosa nell’esplicitare la scorrettezza. Viene aggredita fisicamente da un collega, che le provoca un infortunio sul lavoro con tre settimane di prognosi.
In tutti i casi citati ci troviamo di fronte a discriminazione, così come definita dal Codice delle Pari Opportunità.
Tutti coloro che si trovano toccati dal fenomeno discriminatorio vivono condizioni di lavoro sfavorevole e, in molti casi, somatizzano questo malessere organizzativo.
Ma le condizioni di malessere personale delle vittime rappresentano per le aziende una condizione di danno, se non altro in termini di diminuita produttività. E questo dovrebbe far riflettere anche le aziende.
Il caso di Marina ci fa riflettere su come, molto spesso, le regole siano formalmente seguite ma operativamente ignorate. In molti casi la lavoratrice, per andare incontro alle esigenze dell’azienda viene meno ad un diritto esistente per garantirsi un credito a fronte di esigenze future. Non sempre questa aspettativa viene ripagata.
Molte donne che ricercano aiuto di fronte alle rigidità aziendali lamentano un “tradimento” nei comportamenti aziendali. Si sentono frustrate a fronte di una mancata reciprocità da parte del datore i lavoro in termini di ritorno di quanto in precedenza concesso. Il loro atteggiamento, in seguito, sarà di negazione di qualsivoglia disponibilità e la rottura del clima di fiducia e “familiarità” che credevano di vivere nel contesto lavorativo.
La vicenda di Luca e Giovanna descrive una forma di rigidità dirigenziale. Talvolta, infatti, basta un cambiamento nella dirigenza ed equilibri informali costruiti nel tempo, che garantivano un corretto e fluido svolgimento dell’attività lavorativa, si trasformano in rigidità e conflittualità. E ciò si trasforma in un aggravio di costi diretti ed indiretti per l’azienda, oltre che di malessere per lavoratrici e lavoratori. La riflessione che ne deriva è che piccole flessibilità sono possibili, quando non sono contrattate, anche in via informale soltanto se la dirigenza è capace di comprenderne l’utilità. Se la mancata comprensione viene percepita dall’azienda come un rischio in termini di produttività, si aprono le possibilità di intervento positivo.
Sono ormai numerosi gli esempi di aziende, grandi e piccole, che trovano soluzioni personalizzate per affrontare le problematiche di conciliazione. Quando si è potuto verificare l’impatto delle azioni intraprese, si è registrato nella quasi totalità dei casi un incremento di benessere e di produttività aziendale.
Per quanto riguarda gli altri esempi, oltre agli aspetti più strettamente legati alla produttività aziendale, mi pare doveroso sottolineare quanto una cultura maschilista e una visione distorta della donna e del suo ruolo nella società e nel lavoro incida su comportamenti non solo da condannare ma da combattere.
Il caso di Lucia, Miriam e Carlotta rappresenta una condizione di rischio anche in termini di salute e sicurezza e come tale dovrebbe essere prevenuto e contrastato. La mancata rimozione carica sul datore di lavoro la responsabilità secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Casi, singoli o collettivi, analoghi a questo si rilevano in contesti pubblici e privati, e le imprese sembrano temere il solo riconoscimento della loro esistenza. È mia personale convinzione che tale aumento sia dovuto non solo al clima di incertezza che incrementa le differenze di potere all’interno dei ruoli aziendali, ma anche ad una visione troppo mercificata del ruolo della donna nella società. La pubblicità e la televisione sono i veicoli prevalenti di questa alterazione.
I casi di Caterina e Luisa introducono un riflessione alla quale sto lavorando da qualche tempo. Se le donne (che raggiungono risultati migliori negli studi, che continuano a formarsi anche una volta finito il percorso scolastico) credono nel loro lavoro e – anche in ruoli tecnici e/o in passato prevalentemente maschili – lo svolgono con impegno e serietà, autorità e autorevolezza, possono intimorire quella parte del genere maschile che ancora non accetta i termini di parità.
La violenza potrebbe essere una reazione di questo difficile confronto, alla quale dovremo contrapporre prevenzione, formazione e contrasto fermo e deciso.

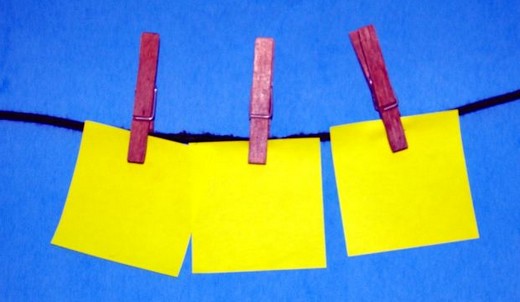 di
di
1 commento
Pingback: 8 marzo 2013: il punto di vista di Rosa Maria Amorevole – Conciliazione plurale