La Patagonia non è luogo di fughe, ma di ritorni, di avventure già avvenute e da raccontare, al riparo dal vento e dalle stelle, attraverso le parole di chi non ha più nulla da perdere e tutto da ricordare.
Prima di partire, nei giorni concitati dei preparativi per il Natale, posso leggere solo “Ultime notizie dal Sud” di Luis Sepulveda, non Chatwin, non Coloane, come invece vorrei.
Comunque non rinuncio a prepararmi alla Patagonia da lettrice, come se questo luogo, più degli altri che ho visitato, mi invitasse a immaginarlo attraverso le parole di un altro, forse perché, a differenza degli altri, sebbene desiderato, non lo sento già mio, o perché, magari, non l’ho desiderato abbastanza.
In due notti riesco a finire il libro di Sepulveda, racconti di incontri straordinari lungo le strade battute dal vento della Patagonia. A letto sono stordita, credo che la malia provenga dal libro, dall’idea dei luoghi, dall’incontro tra parole e luoghi, sempre irresistibile per me. Di questo sono certa.
 Due giorni dopo, finalmente, la Patagonia.
Due giorni dopo, finalmente, la Patagonia.
A Punta Arenas, la luce è grigia e chiara, della consistenza dell’argento fuso. Per le strade sgombre, il silenzio risucchia auto e persone che passano rare. Ecco, la Patagonia mi sembra prima di tutto terra spoglia tra il silenzio e l’odore lontano dell’Oceano.
Il giorno successivo, i raggi del primo sole sono obliqui sul porto di Punta Arenas, ma abbagliano rifrangendosi sul mare. Sul ponte del traghetto sono investita dal vento e dalla luce che si è fatta di nuovo argento. Riesco a vedere la costa, brulla e scura, brullo e scuro è, dunque, l’estremo Sud del mondo; oltre, sullo sfondo, rilievi appena imbiancati. Acqua, vento, luce, terra, nulla di nuovo, tutto nuovo, non basta esserci, bisogna sapere di esserci. Qui acqua, vento, luce e terra appartengono al mito di nomi da carta geografica, stretto di Magellano, Terra del Fuoco, qualche centinaio di chilometri ancora ed è Antartide.
Porvenir è nuovamente silenzio, case piccole e colorate in filari ordinati, orti fioriti e lamiere arrugginite, l’insegna di un hostal e un vecchio osservatorio astronomico.
 Lungo la strada che porta alla pinguinera della Bahia Inutil, il rudere di un’estancia pioniera suggerisce il West americano, ma l’archetipo dell’ultima frontiera qui non è cinema, è letteratura.
Lungo la strada che porta alla pinguinera della Bahia Inutil, il rudere di un’estancia pioniera suggerisce il West americano, ma l’archetipo dell’ultima frontiera qui non è cinema, è letteratura.
Puerto Natales, a circa 250 chilometri a nord di Punta Arenas, si trova nella provincia cilena di Ultima Esperanza, a conferma che la Patagonia è leggenda, ancora prima di assumere i contorni di uno spazio fisico. Il racconto narra del navigatore Ladrillero che attraversò alcuni bracci di mare alla ricerca dello sbocco sul Pacifico, scoperto poi da Magellano, finendo in un vicolo cieco che chiamò Bahia Obstrucción.
A Puerto Natales, comincio a riconoscere la Patagonia di Sepulveda.
Lo spettacolo dal lungomare è estremo, irriducibile, selvaggio. Il fiordo è difeso da una catena di cime innevate che confliggono, nei miei occhi mediterranei, con la presenza del mare in attesa di diventare oceano. A destra, rispetto al mio punto di osservazione, scheletri di imbarcazioni sono spiaggiate come balene e resti di un vecchio molo di legno emergono dall’acqua, sfidando il vento che stasera mi spinge verso l’ultima speranza, nel tramonto senza fine dell’estate australe. Affacciate sul mare, case di lamiera dipinte a colori pastello si appoggiano l’una all’altra e chiudono vite lente e pazienti. Le facce di questi cileni della Patagonia, eredi di avventurieri e cercatori d’oro, hanno i geni di coloro che hanno vissuto tante vite e sanno quando fermarsi perché non si può chiedere oltre alla vita, se l’oltre è qui.
 Nel parco nazionale Torres del Paine, la natura appare come ai primordi della creazione, terra di montagne, acqua liquida di cascate e laghi, poi, ancora acqua, dura di gelo e ghiaccio, e cielo grandissimo che definisce l’immane potenza degli elementi. La parola “paine” in lingua tehuelche significa azzurro, ed è infatti l’azzurro a declinare il colore di rocce, boschi e del fondo dei miei occhi aperti su questa genesi scritta dalla mano di un dio all’inizio dell’opera.
Nel parco nazionale Torres del Paine, la natura appare come ai primordi della creazione, terra di montagne, acqua liquida di cascate e laghi, poi, ancora acqua, dura di gelo e ghiaccio, e cielo grandissimo che definisce l’immane potenza degli elementi. La parola “paine” in lingua tehuelche significa azzurro, ed è infatti l’azzurro a declinare il colore di rocce, boschi e del fondo dei miei occhi aperti su questa genesi scritta dalla mano di un dio all’inizio dell’opera.
Mongolia, Patagonia. In Mongolia, come sulla tela la rappresentazione del vero non può liberarsi dal vincolo del pennello e della mano che lo guida, il paesaggio è arte. Quello della Patagonia, al contrario, è originario, allo stato embrionale, in cui ogni singola parte sperimenta la vita per la prima volta e fatica a diventare sistema coerente. E’ terra ultima al principio della creazione, inizio del tempo e fine dello spazio, un corto circuito che genera un solido e immanente infinito.
Nei giorni a seguire, la Patagonia argentina, a differenza di quella cilena, si distende in una steppa sconfinata interrotta da qualche gauchos a cavallo e greggi bianche a perdita d’occhio.
Al confine tra il Cile e l’Argentina, le Ande meridionali formano il Campo de Hielo Sur, la terza calotta glaciale del mondo dopo Antartide e Groenlandia, a cui appartengono il ghiacciaio Perito Moreno e Upsala.
 Il Perito Moreno ha l’aspetto di una cattedrale gotica in fieri. L’enorme barriera frastagliata di guglie di ghiaccio imprigiona cielo e mare cristallizzando ogni possibile azzurro, ma è anche un gigante fragile che vive di trasformazione. Il ghiaccio cresce, cambia, crepita, scricchiola, cede, si ferisce, restituendosi in parte allo stato fluido e dimostrando che la libertà ha sempre un prezzo da pagare.
Il Perito Moreno ha l’aspetto di una cattedrale gotica in fieri. L’enorme barriera frastagliata di guglie di ghiaccio imprigiona cielo e mare cristallizzando ogni possibile azzurro, ma è anche un gigante fragile che vive di trasformazione. Il ghiaccio cresce, cambia, crepita, scricchiola, cede, si ferisce, restituendosi in parte allo stato fluido e dimostrando che la libertà ha sempre un prezzo da pagare.
Il potente vento patagonico, invece, copre il silenzio del ghiacciaio Upsala, troppo distante per sentirne la voce. Sebbene oggi il cielo sia di nuovo plumbeo, lame di luce accendono a tratti la superficie trasparente delle tre lingue che si immergono nell’immenso lago sottostante, mentre dalle rocce moreniche di fronte è difficile dire se il vento soffia dall’alto o non sia piuttosto il respiro del gigante.
Nell’emisfero australe il Sud è questo, roccia e ghiaccio. E silenzio.
Eppure, in tutto il viaggio, non c’è stato un solo attimo in cui non abbia amato la solitudine e la pace della Patagonia. In questa terra solo apparentemente inospitale l’io si salda alla terra e prende la sua forma, disponendosi all’ascolto, al desiderio che basta a se stesso, all’immaginazione che si fa memoria comune.
La Patagonia non è luogo di fughe, ma di ritorni, di avventure già avvenute e da raccontare, al riparo dal vento e dalle stelle, attraverso le parole di chi non ha più nulla da perdere e tutto da ricordare.
Ora che sono a casa, penso addirittura che potrei tornare in Patagonia per restare, magari tra qualche anno, quando il bisogno di scrivere sarà più forte del bisogno di viaggiare.
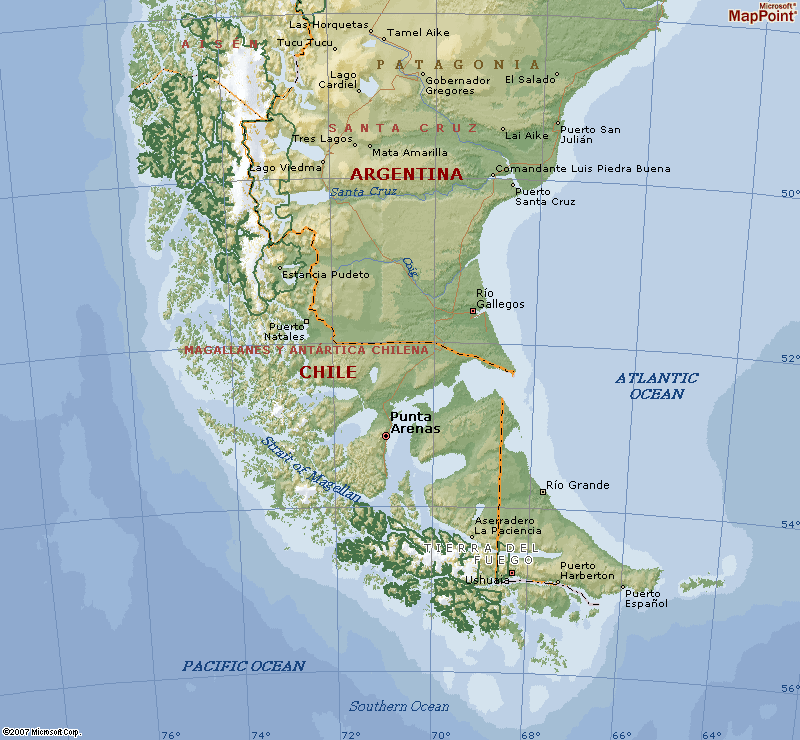 Riprendo il libro di Sepulveda e leggo l’incontro con la “signora dei miracoli”, una vecchietta di novantacinque anni. Miracolose sono le sue mani che hanno il potere di rendere fertili piante, animali, “uomini pieni di vergogna o donne tristi”.
Riprendo il libro di Sepulveda e leggo l’incontro con la “signora dei miracoli”, una vecchietta di novantacinque anni. Miracolose sono le sue mani che hanno il potere di rendere fertili piante, animali, “uomini pieni di vergogna o donne tristi”.
La mia Patagonia, nelle parole dello scrittore: “ Ci chiese se ci piacevano le focaccine fritte, le rispondemmo di sì perché erano davvero buonissime, e mi azzardai a chiederle se viveva sola. -Sola? No, vivo con il mio cane, le pecore, le piante e i fiori- rispose con voce serena, con la lenta cadenza della gente del Sud, con quel modo di parlare che amo, che non ho trovato in nessun altro posto al mondo…, perché la gente del Sud avverte il carattere fondante delle parole, e quando le pronuncia dà vita alle cose che nomina, popolando la durezza della steppa”.

