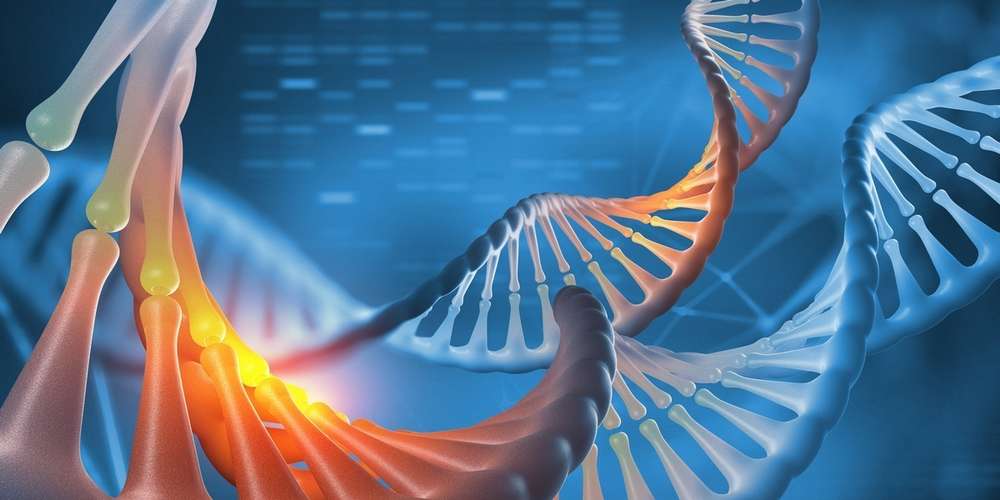L’infertilità è una malattia che rende la coppia disabile. Dicono ma non è sempre vero
Ho letto questa cosa:
L’infertilità è una malattia che rende la coppia disabile.
Il che immagino suoni ai più come un’esagerazione, un pensiero grigio e cupo che ci si aspetterebbe da un predicatore o tutt’al più da chi tenti di venderci un qualche tonico sessuale.
Però se a dirla, questa cosa, è l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, allora è bene prestarci un po’ d’attenzione.
Ebbene, credo che quello che l’OMS intenda quando parla di coppia disabile non sia come ci si aspetterebbe la condizione di difficoltà/diversità in cui due partner che non riescano ad avere figli si ritrovano (quella certa condizione di isolamento e frustrazione) rispetto a un mondo esterno che da sempre pone procreazione e famiglia al centro di tutto.
Non è solo ― voglio dire ― la disabilità della coppia che si sente inadeguata, incapace di attendere alle aspettative di chi sta fuori (che sia la famiglia o la società), quanto più ― io credo ―la disabilità che viene a crearsi proprio dentro la coppia, le inevitabili difficoltà psicologiche e fisiche che allontanano i partner quando si segni tra loro la minacciosa presenza di quella che a ragione oramai definiamo una malattia sociale.
L’infertilità è un vuoto, una mancanza.
In un paese come il nostro, dove il cattolicesimo sia il primo referente etico, dove donna è madre (e talora, in una visione più radicale, solo grembo), l’impossibilità di donare vita e di allargare l’universo dei nostri affetti, l’inettitudine a proiettare il proprio sé nel futuro, è quasi una dannazione all’oblio.
Questo vuoto nella vita di coppia sa diventare straordinariamente ingombrante.
Allontana drasticamente uomo e donna, offuscando (e qualche volta annientando) quel sentimento che li aveva avvicinati.
In questo vuoto, colpa e vergogna attecchiscono come gramigna in un capo secco e quando uomo e donna si rendono conto per certo di non potere essere genitori vengono presi da quella che la medicina chiama crisi d’infertilità (la vergogna per la mancata prova di virilità maschile, la colpa di non potere dare ai genitori dei nipoti, per esempio).
Seppure può accadere che al momento di una diagnosi tanto triste una coppia possa stringersi, trovare un po’ di complicità, unirsi nel dolore (come si dice), bè, a lungo andare questo vuoto, questo “fallimento familiare”, si farà sentire e nel tempo s’insinuerà nella vita sentimentale e di certo anche nella sfera intima, fin quando ogni atto sessuale anche se piacevole costituirà di per sé (tacitamente) un promemoria di quel fallimento.
Ma lo sentite che in quanto ho detto c’è qualcosa che non va?
Lo sentite questo alone nero di disfatta, di pessimismo?
Ecco, questo è quanto comporta tenersi aggrappati ad una tradizione culturale che non ha più alcun senso. Questa visione sconfortante finisce per buttarci giù se ancora oggi ottusamente facciamo fede a quanto credevano i nostri nonni e le nostre nonne o peggio se deleghiamo la nostra salute sessuale (e mentale) a prontuari etici redatti per lo più da maschi (vergini!).
Mi spiego.
Mettiamo un momento da parte le malattie congenite o i decorsi traumatici per cui una donna o un uomo pure in giovane età non possono fare figli.
Vi faccio presente che l’infertilità non è solo patologica, essa è innanzitutto una fase naturale della vita biologica della donna.
Ognuna di noi (tra i 45 e i 50, con la menopausa) si aspetta naturalmente la fine della propria fase riproduttiva (il numero di follicoli ― cellule uovo ― è geneticamente programmato e va diminuendo già dopo i vent’anni, lentamente fino ai 35 circa, velocemente e drasticamente negli anni successivi).
Capita così che molte di noi (sui 35 e non ancora mamme) si trovino a patire per natura le difficoltà di cui parlavo prima.
Dovremmo allora rassegnarci tutte ad una vita di frustrazioni e di “non detti” con in nostri compagni, accettare di essere presto o tardi “disabili”?
Affatto: è a questo punto che la coppia, ma prima di tutto la donna, deve fare i conti con l’esterno (società e cultura).
Se le nonne delle nostre nonne potevano permettersi di fare figli a 18/20 anni, bè francamente oggi… (e lasciamo perdere l’idea di un giovanotto sui 20, cavallo delle brache irragionevolmente calato, la faccia e non solo flagellata di metallo, che si mette a fare il papà o il capofamiglia). No, di certo i tempi (o, come si dice, i costumi) sono cambiati e il momento opportuno per fare famiglia è slittato in avanti di almeno un decennio.
Però il fatto è che l’orologio biologico della donna non è slittato in avanti, e il suo ticchettio è preciso e inesorabile.
Perciò per prevenire quel senso d’inadeguatezza che la “tradizione” sembra non vedere l’ora di appiopparci (arrivate ai trentacinque, psicologicamente ma non biologicamente pronte), dicevo, a soccorso di questa comune condizione femminile di oggi, medicina e scienza si danno da fare per rendere tecnicamente possibile ciò che non lo è più naturalmente.
È bene che ogni donna di oggi si metta in testa che non siamo nel medioevo, né mai più una coppia potrà dirsi (o farsi dire) disabile, con buona pace dell’OMS: fare figli oggi si può.
Badate a quanto ho detto un paio di capoversi fa scrivendo di una donna o un uomo che pure in giovane età non possono “fare figli”.
Ecco, sbagliavo.
Convinciamoci (per il nostro benessere e in nome del rapporto che abbiamo scelto di creare con un uomo a cui volgiamo bene), convinciamoci che tutti possono “fare” figli.
Fare figli non è solo generare, non siamo più solo un grembo da riempire e un figlio non è più solo il frutto del nostro seno.
Fare figli, essere genitori, è scegliere di crescere una creatura trasmettendole (tramandandole) quel progetto d’amore che abbiamo creato come coppia, qualsiasi siano la nostra età (ragionevole ovviamente) e la nostra salute riproduttiva.
Così vale anche per chi è sterile per ragioni non naturali: l’adozione e la fecondazione assistita ci rendono genitori a tutti gli effetti (e quanto a passione e tenacia, forse addirittura genitori migliori).
Questo è quello che un medico deve dire a una coppia sterile che gli si rivolge, questo è quello che uno stato civile dovrebbe dire.
E invece ci deve capitare di assistere a contenziosi surreali sulla fecondazione assistita: un argomento le cui profonde implicazioni psicologiche e sociali solo le donne possono intuire, perché è esclusivamente della nostra esperienza intima che si va a parlare, per cui personalmente provo orrore nel vedere invece uomini (maschi) di potere dissertarne allegramente pretendendo di decidere (immaginate la loro faccia se d’un tratto noi donne ci mettessimo legiferare in materia di disposizioni calcistiche, e la cosa rende l’idea solo alla lontana ― i piedi noi ce li abbiamo, l’utero loro a quanto mi risulta…).
Ma questa è materia molto delicata che merita tutt’altro genere di approfondimento.
In questo senso mi limito solo a un consiglio spassionato: se il nostro paese è barbaro e medioevale in questo senso (e lo è), ben venga quel fenomeno che accumuna un sacco di coppie italiane: “il turismo procreativo”.
In ogni parte del mondo esistono strutture che possono renderci genitori, invito chiunque ne abbia la possibilità a non indugiare e a rivolgersi a loro.
Voglio chiudere portando ad esempio il caso di una mia paziente. Esemplare. Per una chiusura delle tube non poteva avere figli (nel senso italiano, nel senso cattolico). Il sentimento di dispiacere nella coppia si è presto trasformato in depressione patologica e di lì a poco si sono rese necessarie cure psichiatriche. La famiglia ha provato ogni genere di sofferenza, per anni, finché s’è potuto procedere con la fecondazione artificiale. Le era stato detto che non poteva essere mamma e mamma invece lo è diventata. Ora è felice.
Lo ripeto: a tutte le donne, giovani o meno: non cascate nel tranello di chi vi dà delle “disabili”, ciò che di buono ha fatto finora la medicina è cercare di trovare per ognuna di noi una soluzione personale e soddisfacente, per cui l’unica nostra preoccupazione debba rimanere l’affetto sincero che proviamo per colui che abbiamo scelto come padre dei nostri figli.
E ai medici obbiettori che non condividono questo pensiero (per cui evidentemente il rispetto della tradizione eucaristica viene prima della salute mentale delle pazienti), bé mi sento di suggerire loro di recarsi a prestare servizio in qualche remota regione islamica integralista dove forse le loro convinzioni saranno considerate eque e democratiche.