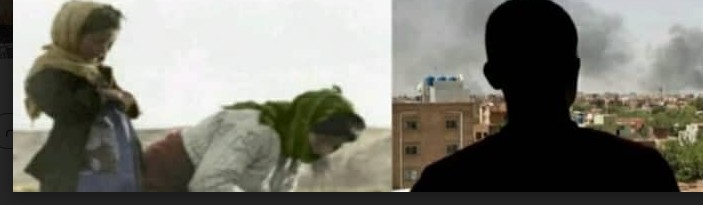Oggi ricorre il 108° anniversario del genocidio armeno, terra dolente e antica detta “culla dell’umanità”. Ma è anche il suo contrario: culla e tomba. Quella armena ha rappresentato, infatti, la prima “soluzione finale” del Novecento, una prova tecnica di strage cui i nazisti si ispirarono per attuare la Shoah. E ancor oggi nominarne il calvario è tabù: in alcuni paesi si rischiano crisi diplomatiche senz’appello.
La tragedia dell’Armenia, che ha inaugurato il secolo più sanguinoso della storia umana e che, significativamente, viene ricordata il 24 aprile, riassume il senso di tutte le guerre passate e future: la lotta per il potere, strettamente legata all’antiumanesimo e al transumanesimo. Conseguenziale all’eliminazione del simbolo per eccellenza dell’umanità, le donne e i giovani. Le une con la loro potenza generativa, gli altri con l’energia rinnovata della natura. La distruzione di questi baluardi antropologici cancella il concetto di cura e il patto sociale, con la logica rottura delle relazioni tra cittadini e popoli e della trasmissione di civiltà: a farne le spese sono quindi anche gli anziani e i soggetti fragili, non “efficienti” e pertanto “inutili”.
L’eccidio armeno, con le sue vittime (donne, ragazze/i, cristiane convertite a forza e costrette a uccidere i propri figli), viene evocato nel momento in cui nel Sudan (altro paese giovane e “femminile“) si combatte una guerra che gli occidentali woke ignorano platealmente malgrado la retorica parolaia sull’inclusione. Non possiamo celebrare degnamente la Liberazione domani se non scardiniamo gli attuali nazifascismi, ovunque si verifichino.